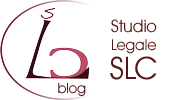Abbiamo già parlato in diverse occasioni dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, che ha la funzione di assicurare loro cura, assistenza, istruzione ed educazione.
Come abbiamo già visto, l’obbligo di versarlo è individuato in capo ad uno dei due coniugi, tendenzialmente quello non affidatario; la corresponsione dell’assegno non ha solamente un risvolto legale ma ha anche un importante rilievo psicologico, in quanto serve come sostegno per il genitore che vive con i figli e che quindi si trova a far fronte ad una nuova gestione delle incombenze quotidiane.
La disciplina dell’assegno di mantenimento discende da un dovere impartito ai genitori a livello costituzionale, vale a dire il dovere di mantenimento della prole.
In particolare, l’art. 30 della Costituzione ma anche l’art. 147 del Codice Civile stabiliscono che entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Se accade che i genitori si separano, la legge stabilisce che sia il giudice a determinare «la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli».
È qui, dunque, che il giudice individua le condizioni economiche che dovranno essere adottate nell’ambito della separazione (o del divorzio) ed interviene, talvolta, stabilendo che uno dei due coniugi debba corrispondere all’altro un assegno di mantenimento.
Entriamo ora nel vivo dell’argomento che vogliamo approfondire.
Le spese necessarie al mantenimento dei figli si dividono in due categorie: ordinarie e straordinarie.
Quando il giudice determina l’ammontare dell’assegno, prende in considerazione solo le spese ordinarie, ovvero quegli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio che devono essere sostenuti in modo costante, anche eventualmente ad intervalli regolari ampi.
Per quanto riguarda le spese straordinarie, invece, il giudice si limita ad individuare la percentuale del contributo gravante su ogni coniuge e, solitamente, ripartisce il carico al 50% ciascuno.
In alternativa, individua una quota diversa in ragione della differente capacità economica tra i coniugi.
Ma quali sono, dunque, le spese straordinarie?
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 40281 del 15.12.2021, ha ricordato che per spese straordinarie si intendono quelle spese che «per la loro rilevanza, per la loro imprevedibilità e per la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli».
Dunque, le spese straordinarie si caratterizzano per la loro eccezionalità: sono straordinarie tutte le spese che non sono prevedibili o che sono “una tantum”.
Per esempio, le spese necessarie per il pagamento di un intervento chirurgico o per l’acquisto di un’automobile sono straordinarie, in quanto non sono prevedibili nel caso dell’intervento e non sono ripetibili con frequenza abituale quanto all’automobile.
Per fare chiarezza e non lasciar spazio a dubbi di sorta, il Tribunale di Milano ha individuato una lista di spese che sono da considerare come straordinarie: l’elenco è disponibile qui, riportiamo alcuni punti a titolo esemplificativo: visite specialistiche, cure dentistiche, occhiali/lenti a contatto per uso medico, gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio in Italia e all’estero, attività sportive, iscrizioni a gare e tornei…
L’elenco individuato dal Tribunale di Milano contiene comunque solo delle linee-guida e quanto in esso stabilito non può esser considerato vincolante. Infatti, ci sono Tribunali che utilizzano dei criteri più stringenti mentre altri, al contrario, includono anche spese diverse e non incluse nell’elenco.
Ti è piaciuto questo articolo? Lasciaci un commento!
Potrebbe interessarti anche:
Assegno di mantenimento per i figli
Assegno di divorzio all’ex coniuge che convive con un’altra persona
Separazione e figli minori: quali conseguenze?