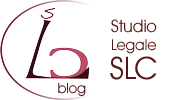Da qualche mese gli studiosi del diritto civile si stanno interrogando sulla qualificazione giuridica del Covid 19 e sugli effetti della pandemia sulle varie fattispecie negoziali.
Seppur la questione non sia ancora oggi del tutto pacifica, non si può comunque non aderire alla visione dei più circa la natura dell’emergenza sanitaria in atto di una causa estranea alla volontà delle parti contrattuali.
Da quanto sopra consegue che, seppur il Covid 19 abbia significativamente aumentato il rischio di “inadempimento contrattuale”, merita comunque di essere evidenziato che – in molti casi- un vero e proprio “inadempimento” ex art. 1218 cc non è, considerando che la responsabilità contrattuale sussiste solo quando la causa dell’inadempimento risulti “imputabile” alla parte.
Ad ogni modo, quanto sopra non può in ogni caso essere generalizzato. È ben possibile, infatti, che molti rapporti obbligatori siano rimasti impregiudicati nonostante l’emergenza, e perciò – se la prestazione promessa è ancora possibile – il rifiuto del debitore o di entrambi i contraenti di adempiere dovrà ritenersi ingiustificato (si pensi ad esempio all’acquirente che ha ricevuto la cosa in consegna dal venditore ma decida “causa covid” di non pagarne il prezzo).
A quanto sopra deve altresì aggiungersi che il nostro ordinamento giuridico non si limita a disciplinare l’inadempimento contrattuale, ma tratta anche di vere e proprie situazioni patologiche che – piuttosto che essere legate alla responsabilità di una delle parti – sono ex se ritenute validi motivi per dar fine ad un accordo.
Si pensi all’impossibilità sopravvenuta della prestazione che, come sopra accennato, non permette di ascrivere alcuna responsabilità in capo alla parte inadempiente ma, se assoluta, in virtù di quanto disposto dall’art. 1256 cc, ha comunque quale effetto quello di estinguere l’obbligazione.
Se, dunque, il Covid 19 dovesse rendere una data prestazione impossibile da eseguire, ovvero far venir meno l’interesse del creditore a conseguirla in un momento successivo, si può allora ragionevolmente dire che esso dà fine al rapporto obbligatorio precedentemente instaurato dalle parti.
In determinati casi, soprattutto per quanto riguarda le obbligazioni pecuniarie, l’emergenza sanitaria può invece non incidere sull’impossibilità di eseguire il contratto (es. un pagamento ben può essere fatto telematicamente), ma sul vantaggio economico che le parti avrebbero voluto ricavare dallo stesso.
Ogni contratto è dunque a sé stante e presuppone un’analisi critica differente a seconda della sua natura e/o delle prestazioni che esso ha ad oggetto.
Particolare attenzione merita di essere data ai contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, quindi a quei contratti che non si estinguono con l’esecuzione di una singola ed isolata prestazione (si pensi all’abbonamento mensile di una palestra ovvero alle rette scolastiche degli istituti privati), ma che appunto vengono eseguiti ogni giorno per un dato periodo ovvero a cadenza mensile o annuale.
In tali contratti un evento “straordinario e imprevedibile”, come il Coronavirus, potrebbe anche rendere eccessivamente “onerosa” la prestazione di una delle parti, che non è più in grado di continuare ad adempiere alle stesse condizioni pattuite. In questi casi, l’art. 1467 cc. espressamente stabilisce che la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto in essere all’altra parte la quale, tuttavia, può “evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto “, magari riducendo il corrispettivo, ripristinando così l’equilibrio negoziale.
Per concludere, gli effetti giuridici del Covid-19 sui contratti stipulati variano caso per caso e dipendono da una molteplicità di fattori che devono essere valutati sistematicamente, e tra questi vi è anche la possibile presenza di clausole specifiche che espressamente neutralizzano l’incidenza di circostanze eccezionali sul rapporto obbligatorio.
Ad ogni modo, la dottrina prevalente sembra oggi fare un passo ancora più lungo, affermando che debba in verità sussistere un vero e proprio obbligo delle parti di “rinegoziare il contratto”, riformulandolo in virtù dell’emergenza sanitaria. Se si aderisce a tale tesi, che ha quale base giuridica i principi di buona fede e correttezza ex art. 1173 cc, 1373 cc., nonché il principio solidalistico costituzionalmente garantito dall’art. 2 Cost, allora il rifiuto della controparte di “rinegoziare” diventerebbe così un vero e proprio inadempimento contrattuale.
Ti è piaciuto questo articolo? Lasciaci un commento!
Potrebbe interessarti anche:
Covid-19: la fase 2 ed il Covid Manager
Covid-19: è giusto pagare le rette scolastiche?
L’importanza di un contratto personalizzato
Ultimi post di Avv. Laura Citroni (vedi tutti)
- WEDDING PLANNER E ASPETTI LEGALI: COSA SAPERE - 16/04/2025
- AFFITTI BREVI E QUIETE CONDOMINIALE: UNA CONVIVENZA DIFFICILE? - 10/04/2025
- MATERNITA’ SURROGATA: ORA E’ UN REATO UNIVERSALE - 02/04/2025